Prima di iniziare lo studio delle tavole relative agli schemi elettrici industriali e agli schemi elettropneumatici, è opportuno presentare il funzionamento di alcuni schemi di base.
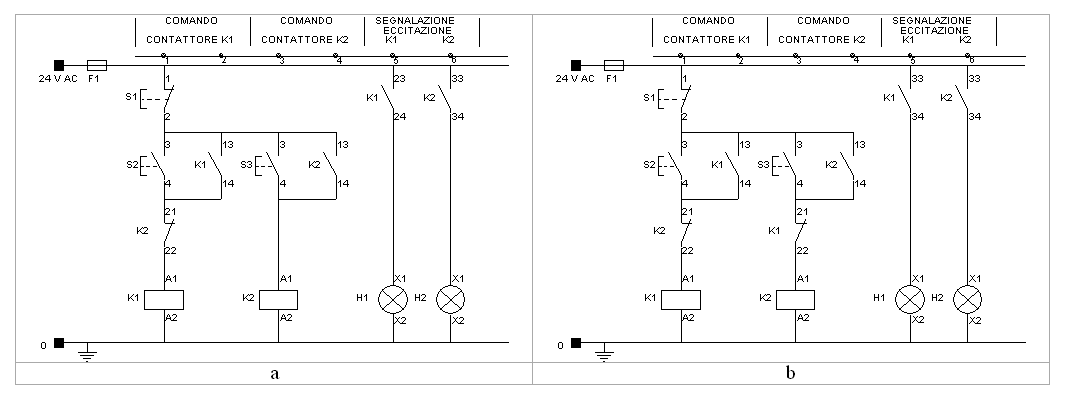
Prima di iniziare lo studio delle tavole relative agli schemi elettrici industriali e agli schemi elettropneumatici, è opportuno presentare il funzionamento di alcuni schemi di base, che impiegano contattori e temporizzatori, utili per la comprensione di schemi più complessi. Innanzitutto vediamo di spiegare il concetto di autoalimentazione.
Fig. 3 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Si osservi lo schema mostrato nella fig. 3a. Premendo il pulsante S1, il contattore o relè K1 si eccita (morsetti A1-A2), di conseguenza il suo contatto cambia stato e la lampada H1 si accende. Rilasciando il pulsante S1, il contattore si diseccita e la lampada H1 si spegne. Volendo che la lampada rimanga accesa si deve modificare lo schema mostrato nella fig. 3a trasformandolo nello schema 3b.
Fig. 4 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Si deve inserire in parallelo al pulsante S1 un contatto normalmente aperto NA (oppure NO = Normally Open) del contattore K1, detto contatto di autoalimentazione o di ritegno. Questo impedisce la diseccitazione di K1 e, anche rilasciando S1, la lampada H1 rimane accesa. Per diseccitare il contattore è necessario inserire in serie al circuito della bobina un pulsante S2 con un contatto normalmente chiuso (NC = Normally Close), come è possibile vedere nello schema di fig. 4a. Volendo segnalare l’eccitazione e la diseccitazione del contattore, si può procedere come mostrato nella fig. 4b. La lampada H2 si accende all’eccitazione del contattore K1, mentre la lampada H1 si accende solo quando il contattore K1 è diseccitato. A questo scopo si fa uso di un contatto NO e di un contatto NC di K1 (fig. 4b).
Fig. 5 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Viene mostrata di seguito (fig. 5a) un’applicazione di ciò che è stato visto precedentemente, cioè lo schema funzionale per il comando di un motore asincrono trifase. Nello schema, infatti, possiamo trovare: il pulsante S1, che permette l’eccitazione del contattore di alimentazione del motore K1; il pulsante S2, per la diseccitazione di K1 (arresto del motore); il contatto NC (95-96) del relè termico F2, posto a protezione del motore, che permette la diseccitazione automatica di K1; il contatto NO (97-98) del relè termico F2 di alimentazione della lampada H1 che segnala l’intervento del dispositivo di protezione; le segnalazioni H2 e H3 alimentate, rispettivamente, da un contatto NC e NO di K1 che indicano lo stato di eccitazione di K1 (arresto e marcia del motore).
È interessante notare come il contatto NO di autoalimentazione di K1 sia in parallelo al pulsante S1 e come il comando di arresto S2 sia prioritario rispetto al comando di marcia (tenendo premuto S2, anche premendo S1 il contattore non si eccita). Negli schemi per il telecomando di motori e, più in generale, nell’automazione industriale viene scelta questa soluzione perché garantisce una maggiore affidabilità in fatto di sicurezza degli impianti. La soluzione proposta qui di seguito (fig. 5b), anche se dal punto di vista logico permette gli stessi risultati, non è altrettanto valida dal punto di vista della sicurezza. Infatti, in questo caso, se vengono premuti contemporaneamente i due pulsanti S1 e S2, è S1 a prevalere su S2, mantenendo eccitato il contattore K1, anche con il pulsante di arresto S2 premuto. In questo secondo caso, è il comando di marcia S1 ad essere prioritario rispetto al comando di arresto S2.
In entrambi i casi le lampade di segnalazione H1, H2, H3 indicano, rispettivamente, l’intervento del relè termico F2, la diseccitazione e l’eccitazione di K1 (arresto e marcia del motore). Vediamo ora alcuni casi di interdipendenza tra contattori. I contatti NC possono servire anche per evitare che due o più contattori si eccitino contemporaneamente, come viene indicato nello schema di fig. 6a. Premendo il pulsante S2, si eccita il contattore K1 che rimane autoalimentato. Premendo ora il pulsante S3, si eccita il contattore K2, il quale diseccita il contattore K1. Da notare che con K2 eccitato, premendo S2, il contattore K1 non si eccita (contatto di interblocco 21-22 di K2). Infine, se si preme il pulsante S1, si diseccita il contattore che è eccitato (K1 o K2). Completano lo schema due lampade di segnalazione che indicano quale dei due contattori è eccitato: H1 segnala l’eccitazione di K1, mentre H2 l’eccitazione di K2. Esaminiamo ora lo schema di fig. 6b dove, con il contattore K1 eccitato, non si possa eccitare K2 e viceversa. In questo esempio una volta che si è eccitato uno dei due contattori, il rispettivo contatto NC (21-22) impedisce all’altro contattore di eccitarsi, anche se viene premuto il pulsante di marcia (contatto di interblocco). Infine se si preme il pulsante S1 si provoca la diseccitazione del contattore eccitato.
Fig. 6 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Completano lo schema due lampade di segnalazione che indicano quale dei due contattori è eccitato; in particolare, H1 segnala l’eccitazione di K1, mentre H2 l’eccitazione di K2. Questo schema trova applicazione per effettuare il cambiamento del senso di rotazione di un motore asincrono trifase, oppure per effettuare il comando di due motori in modo tale che sia impossibile far funzionare i due motori contemporaneamente. Per segnalare, invece, la condizione di riposo dei due contattori si devono collegare in serie, alla lampada di segnalazione H1, i contatti NC di entrambi i contattori (K1 e K2), come viene mostrato nello schema di fig. 7 (lo schema è identico nel circuito di comando dei contattori alla fig. 6b).
Fig. 7 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Si vuole ora fare in modo che il contattore K2 si possa eccitare solo dopo l’eccitazione di K1. Dallo schema di fig. 8 si vede che il contattore K2 non si può eccitare se il contattore K1 non è eccitato (contatto di K1 23-24 chiuso). Con i contattori entrambi eccitati, premendo il pulsante S3, si diseccita solo K2 senza provocare la diseccitazione di K1. Per diseccitare K1 è necessario premere il pulsante S1.
Fig. 8 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Fig. 9 - Esempi di circuiti base (clicca per ingrandire)
Vediamo ora due schemi che prevedono una interdipendenza tra due contattori alla diseccitazione. Si osservino gli schemi di fig. 9. Nel primo schema (fig. 9a) con il pulsante S4 si eccita il contattore K2, che si può diseccitare con il pulsante S3 solo se il contattore K1 è eccitato. Infatti, il contatto NC di K1 (21-22) cortocircuita il pulsante di arresto S3, impedendo la diseccitazione di K2. Il contattore K1, invece, si può eccitare e diseccitare indipendentemente da K2 premendo, rispettivamente, i pulsanti S2 e S1. Nel secondo schema (fig. 9b), invece, premendo il pulsante S4, il contattore K2 si eccita e si può diseccitare, a differenza dello schema precedente, solo se K1 è diseccitato. In questo caso è il contatto NO di K1 (23-24) a mettere in cortocircuito il pulsante di arresto S3 quando K1 è eccitato.
Anche in questo caso il contattore K1 si può eccitare e diseccitare indipendentemente da K2 premendo rispettivamente i pulsanti S2 e S1. Nella stesura degli schemi elettrici funzionali, però, si possono verificare dei funzionamenti incerti. Esaminiamo ad esempio lo schema mostrato nella fig. 10a. Azionando il pulsante S1, il contattore K1 riceve l’alimentazione per un tempo di durata molto breve poiché il contatto NC, posto in serie al pulsante, si apre rapidamente togliendo, come si è detto, l’alimentazione a K1.
Fig. 10 - Esempi di circuiti dal funzionamento incerto (clicca per ingrandire)
L’impulso può tuttavia essere sufficiente a consentire la chiusura del contatto NO e a far sì che la bobina si autoalimenti. In caso contrario, la parte mobile del contattore viene attratta per un attimo e quindi ritorna, per effetto della molla di rimando, nella posizione di riposo. Una tale condizione di funzionamento si ripete fino a quando si tiene premuto il pulsante S1. Se, invece, il contatto NC di K1 viene inserito direttamente sulla bobina come rappresentato nello schema di fig. 10b, premendo il pulsante S1 il contattore non si può autoalimentare. Si manifesterebbero quindi inevitabili vibrazioni della parte mobile del nucleo del contattore. Si noti che, utilizzando i contatti ausiliari normali, il contatto NC di K1 si apre prima che si chiuda il rispettivo contatto NO.
Fig. 11 - Esempi di circuiti dal funzionamento incerto (clicca per ingrandire)
Vediamo ora altri circuiti dal funzionamento incerto. In questo altro esempio (fig. 11a) premendo il pulsante S2 non si sa quale dei due contattori si ecciti prima, escludendo di conseguenza l’altro, a causa della presenza dei due contatti di interblocco K1 e K2. Nel caso della fig. 11b, azionando il pulsante S1 si eccita il contattore K2 e quindi il contattore K1, ma l’autoalimentazione di K1 è incerta perché esso diseccita il contattore K2.
Fig. 12 - Esempi di circuiti base per l’inserzione di lampade di segnalazione (clicca per ingrandire)
Per quanto riguarda l’inserzione delle lampade di segnalazione, è buona regola non collegare le lampade di segnalazione direttamente in parallelo alle bobine dei contattori (fig. 12a). Durante la diseccitazione del contattore si produce, ai capi della bobina, una sovratensione di origine induttiva che potrebbe ridurre la vita della lampada posta in parallelo ad essa. Oltre a ciò il pulsante è attraversato, durante l’eccitazione del contattore, dalla corrente assorbita dalla lampada. Per evitare questi inconvenienti, si consiglia di inserire la lampada come rappresentato nello schema di fig. 12b. Tale soluzione presenta il vantaggio di rendere il circuito di segnalazione completamente indipendente dal resto del circuito. Inoltre, la lampada H1, quando si accende, segnala se il relè K1 si è eccitato e, quindi, se ha mosso effettivamente i suoi contatti. Infine, se H1 rimane accesa, anche a relè K1 non alimentato, significa che il relè si è danneggiato (contatti incollati).
Vediamo ora due esempi relativi all’uso dei relè a tempo o temporizzatori. I temporizzatori ritardati all’eccitazione, nella loro costruzione più semplice e più frequentemente usata, sono costituiti da una bobina che aziona un dispositivo di ritardo, il quale va ad agire su uno o più contatti che, in questo caso, si muovono dopo un certo tempo dall’eccitazione della bobina (A1-A2). Nello schema riportato nella fig. 13a, premendo il pulsante S2, il contattore istantaneo K2 si eccita immediatamente, chiudendo i suoi contatti: il primo (13-14) di autoalimentazione e il secondo (23-24) che alimenta la lampada di segnalazione H1 la quale si accende immediatamente. Il temporizzatore K1, invece, una volta alimentato, chiuderà il suo contatto (7-8) dopo 5 s, permettendo così l’accensione con ritardo della lampada H2. Premendo il pulsante S1, il temporizzatore K1 e il contattore K2 si diseccitano; i loro contatti ritorneranno immediatamente nella posizione di riposo, spegnendo così contemporaneamente le due lampade di segnalazione H1 e H2.
I temporizzatori ritardati alla diseccitazione sono caratterizzati da due morsetti A1-A2 di alimentazione e da due morsetti B1-B2 che attivano il dispositivo di ritardo, il quale va ad agire su uno o più contatti. Nello schema riportato nella fig. 13b, premendo il pulsante S2 si ottiene istantaneamente lo spegnimento della lampada H1 mediante il contatto NC (5-6) ad apertura immediata, ma ritardato alla chiusura, e l’accensione della lampada H2 mediante il contatto NO (7-8) a chiusura immediata e ritardato all’apertura. Premendo il pulsante S1, infatti, tornerà ad accendersi la lampada H1 e a spegnersi la lampada H2 dopo un determinato tempo (in questo caso, pari a 3 s), tramite i due contatti NO e NC ritardati alla diseccitazione. Da notare il simbolo della bobina del temporizzatore K1, diverso dal caso precedente. Nella fig. 13a il contattore K2 alimenta la bobina del temporizzatore K1 mediante il suo contatto di autoalimentazione (13-14), mentre nella fig. 13b viene utilizzato il contatto (23-24) per attivare il ritardo alla diseccitazione.
Fig. 13 - Esempi di circuiti base che utilizzano temporizzatori (clicca per ingrandire)
Fig. 14 - Esempio di circuito base che utilizza un temporizzatore ritardato all’eccitazione (clicca per ingrandire)
Si vuole infine far notare come sia possibile avere dei contatti ritardati alla diseccitazione senza disporre dell’apposito temporizzatore. Lo schema riportato nella fig. 14 utilizza infatti un normale (e più diffuso) temporizzatore ritardato all’eccitazione che, associato ad un normale relè monostabile, consente di raggiungere il risultato desiderato. Se si preme il pulsante S1, il relè K2 si autoalimenta e permette il funzionamento del temporizzatore K1, il quale dopo che è trascorso il tempo impostato apre per un attimo il suo contatto NC (5-6) diseccitando se stesso e il relè K2, aprendo così il contatto di autoalimentazione (13-14). Il risultato che si ottiene utilizzando i contatti di K2 è il seguente: dopo aver premuto il pulsante S1, il contatto NC (21-22), aprendosi istantaneamente, spegne la lampada H1, mentre il contatto NO (33-34) accende la lampada H2; trascorso il tempo impostato (per esempio, 3 s), automaticamente H1 si riaccenderà di nuovo, mentre H2 si spegnerà.
Fig. 15 - Esempio di trasformazione di un circuito dal funzionamento incerto in un circuito dal funzionamento sicuro (clicca per ingrandire)
Nell’uso dei temporizzatori è opportuno porre attenzione a non effettuare dei collegamenti che possano dare origine ad un funzionamento incerto. Nei seguenti schemi viene mostrato come si può evitare un possibile funzionamento incerto di un temporizzatore (K2) utilizzato per diseccitare il relè K3 e per eccitare contemporaneamente il relè K4. Il primo schema (fig. 15a) prevede un pulsante di marcia S2 e un pulsante di arresto S1 in grado di diseccitare tutto in qualsiasi istante; premendo S2 si eccita il relè K1 il quale alimenta, attraverso il contatto NC di K4, il temporizzatore che, trascorso il tempo impostato (per esempio, 3 s), muove i suoi contatti diseccitando K3 ed eccitando K4. In realtà il funzionamento dello schema di sinistra risulta incerto. Infatti, nel momento in cui il temporizzatore muove i suoi contatti, il contatto NC (5-6), aprendosi, diseccita K3 e il contatto NO (7-8), chiudendosi, eccita il relè K4. Viene in tal modo a mancare l’alimentazione proprio al temporizzatore in quanto K4, eccitandosi, apre il contatto che alimenta K2; in definitiva, perciò, non è detto che K4 riesca ad autoalimentarsi. Mantenendo alimentato il temporizzatore è possibile però eliminare ogni incertezza sul funzionamento dello schema, come è mostrato nello schema di destra (fig. 15b).
Fig. 16 - Esempio di trasformazione di un circuito dal funzionamento incerto in un circuito dal funzionamento sicuro (clicca per ingrandire)
Un altro modo per eliminare i problemi riguardanti i collegamenti che provocano un funzionamento incerto è presentato nella fig. 16. Nello schema di sinistra (fig. 16a), quando si preme il pulsante S2 di marcia, viene eccitato il relè K1 il quale permette l’alimentazione del temporizzatore K2 per mezzo del contatto (23-24). Il temporizzatore, trascorso il tempo impostato (5 s), chiude il suo contatto NO (7-8) che, a sua volta, provoca l’eccitazione del relè K3, il quale agisce sui suoi contatti, in particolare apre il contatto NC (11-12) e chiude il contatto NO (23-24). Durante questa fase, il contatto di K3 (11-12) toglie l’alimentazione al temporizzatore K2, il quale riapre il suo contatto (7-8); si viene così a creare un funzionamento incerto, in quanto non è sicuro che il relè K3 possa effettivamente autoalimentarsi mediante il suo contatto NO (23-24): in alcuni casi, il ciclo potrebbe arrestarsi. Per eliminare il funzionamento incerto è possibile utilizzare la soluzione proposta nello schema di destra (fig. 16b), dove è stato aggiunto un relè (K5).
Fig. 17 - Esempio di uso contemporaneo dei contatti NO e NC di un pulsante (clicca per ingrandire)
Quando il temporizzatore K2 attiva il suo contatto NO (7-8), eccita il relè K5 il quale chiude i suoi contatti (13-14) di autoalimentazione e il contatto (23-24) che alimenta il relè K3, il quale, a sua volta, agisce togliendo l’alimentazione al temporizzatore K2. In questo modo si ottiene un funzionamento corretto, in quanto il sicuro stato di eccitazione di K5 (si è autoalimentato) consente di proseguire con sicurezza il ciclo. Il ciclo prevede, con l’eccitazione di K3, anche l’alimentazione del temporizzatore K4 che a sua volta, trascorso il tempo impostato di 6 s, diseccita K5, K3 e K4; in particolare, il contatto di K3 NC (11-12) a questo punto si richiude, restituendo l’alimentazione al temporizzatore K2 il quale, automaticamente, avvia un nuovo ciclo. Per arrestare il ciclo in qualsiasi istante è sufficiente premere il pulsante di arresto S2. L’ultimo schema proposto (fig. 17) mostra come sia possibile utilizzare i contatti normali NO e NC di un pulsante (S2) per realizzare un automatismo che prevede il comando in sequenza di tre relè: K1, K2 e K3; da notare che i contatti NC di S2 si aprono prima che si chiudano i contatti NO. Lo schema ha il seguente funzionamento: se si preme il pulsante S2, si eccita il relè K1, se si rilascia S2, si eccita il relè K2 e se si preme di nuovo S2, si eccita il relè K3. I relè rimangono eccitati per mezzo dei rispettivi contatti di autoalimentazione.
Premendo il pulsante S1 in qualsiasi istante è possibile diseccitare tutti i relè che in quel momento sono eccitati. Aumentando il numero dei contatti di S2, secondo quanto mostrato precedentemente e modificando il circuito di comando, è possibile aumentare il numero dei relè da eccitare in sequenza.














