In questo paragrafo saranno presentate le caratteristiche generali degli schemi elettropneumatici e più in generale gli schemi elettrici usati nell’automazione industriale.
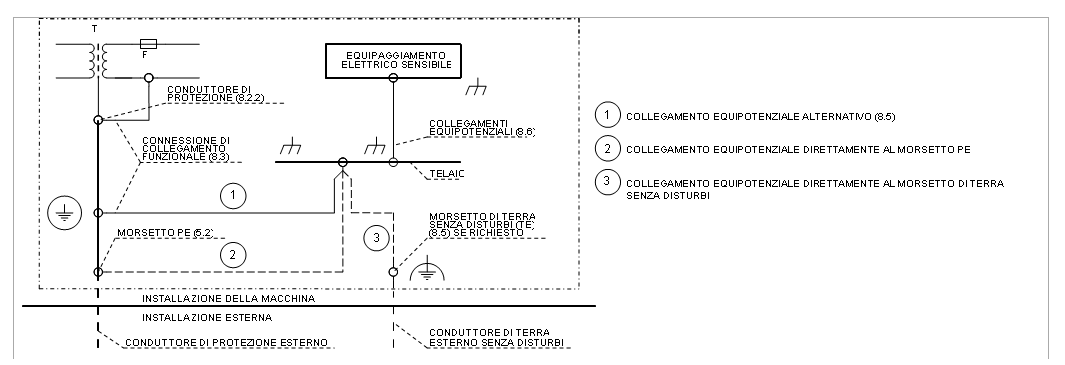
In questo paragrafo saranno presentate le caratteristiche generali degli schemi elettropneumatici e più in generale gli schemi elettrici usati nell’automazione industriale presentati in questo capitolo ed in quello successivo.
Gli schemi, presentati in ordine di difficoltà crescente, sono accompagnati dallo schema di potenza e dallo schema funzionale; possono altresì essere utilizzati per lo studio dei controllori logici programmabili (PLC) trasformando la logica cablata tradizionale in logica programmata tipica dei PLC.
Gli schemi presentati possono considerarsi degli schemi “tipo”. Se necessario, per realizzare impianti più complessi, è possibile modificare, ampliare oppure unire i diversi schemi ed ottenere l’impianto per l’applicazione che si desidera. Ogni circuito presentato risulta equipaggiato da un certo numero di indicatori luminosi che segnalano le diverse sequenze di manovra e di consenso. Oltre a quelle proposte, se ne possono aggiungere altre, in base alle proprie esigenze di controllo e di supervisione dell’impianto e della macchina.
Per la designazione dei componenti e dei colori delle lampade e dei pulsanti si è fatto riferimento alle norme CEI. La numerazione dei morsetti, anch’essa conforme alle norme CEI, fa riferimento in particolare alla serie normalizzata E. I segni grafici utilizzati sono conformi ai fascicoli delle norme CEI emesse dal Comitato Tecnico 3, riportate in questo capitolo, in cui sono stati riuniti i simboli più utilizzati. Sono mostrate le principali regole per la preparazione della documentazione che deve accompagnare ogni impianto o macchinario. Negli schemi sono riportati anche i morsetti, indicati con dei quadratini neri, relativi alla connessione fra i circuiti di comando interni alla cassetta o all’armadio elettrico e quelli periferici relativi al campo (pulsantiere, sensori, finecorsa, ecc.). Ogni circuito di potenza prevede un interruttore di potenza (per esempio, Q0) posto sul portello del quadro elettrico al fine di togliere l’alimentazione sia agli utilizzatori di potenza sia ai circuiti ausiliari.
Fig. 18 - Esempio di collegamenti equipotenziali di protezione su di una macchina operatrice (Fig. 3 della norma CEI 44-5) (clicca per ingrandire)
Sempre nel circuito di potenza si può notare come i motori elettrici (in genere asincroni trifasi) siano protetti contro i cortocircuiti mediante fusibili, mentre la protezione contro i sovraccarichi è demandata ai relè termici. L’intervento di questi relè provoca in genere l’arresto dell’impianto o di una parte di esso e, contemporaneamente, l’attivazione del circuito di segnalazione che, in alcuni casi, è acustico e luminoso.
Per riattivare l’impianto è necessario ripristinare il relè termico, dopo aver eliminato l’anomalia che ne ha provocato l’intervento e, quindi, dare gli opportuni comandi per la ripresa del ciclo. Nei primi impianti viene proposta, inoltre, una possibile disposizione delle apparecchiature nel quadro di comando, comprendenti quelle appartenenti al circuito di potenza e ai circuiti ausiliari, nonché la morsettiera necessaria per i collegamenti con il campo. I circuiti di comando, in base alla norma CEI 44-5, vengono utilizzati per pilotare il funzionamento di una macchina, di un automatismo, ecc. Possono essere realizzati per funzionare in corrente alternata o continua, ma per l’alimentazione occorre utilizzare trasformatori con avvolgimenti separati. La norma non precisa valori preferenziali per la tensione di comando, indicando solo in 250 V il valore massimo consentito. La scelta del valore di una tensione troppo bassa può dar luogo a inconvenienti funzionali, specialmente se si lavora in ambiente polverosi, mentre tensioni troppo alte comportano difficoltà di isolamento negli apparecchi di comando.
Normalmente si sceglie il valore di 110/115 V; per i circuiti di segnalazione, se sono alimentati separatamente, si preferisce la tensione di 24 V. La norma CEI 44-5 prescrive che i circuiti di comando siano protetti contro i cortocircuiti ed eventualmente contro i sovraccarichi; quest’ultima eventualità può risultare opportuna nei casi in cui, per il fatto della non contemporaneità dei vari comandi, la potenza del trasformatore di alimentazione risulti inferiore alla somma delle potenze richieste dai vari circuiti. Occorre inoltre fare in modo che un’eventuale interruzione improvvisa di alimentazione sui circuiti di comando non comporti situazioni di pericolo per la macchina azionata. Il collegamento al circuito di protezione di una polarità del trasformatore che alimenta i circuiti di comando permette di rilevare, mediante l’intervento delle protezioni di massima corrente, eventuali guasti nell’isolamento verso massa, purché tutte le masse siano a loro volta collegate al circuito di protezione.
Tale collegamento, utile per rilevare possibili difetti all’isolamento, presenta anche vantaggi dal punto di vista funzionale, perché evita la possibilità che eventuali guasti a terra provochino un funzionamento intempestivo. Per l’alimentazione dei circuiti ausiliari si è preferito, negli schemi che seguiranno, utilizzare un trasformatore di isolamento o di sicurezza per farli funzionare con una bassissima tensione (<=50 V). Il trasformatore viene normalmente posto all’interno del quadro elettrico; in alternativa, è possibile alimentare i circuiti ausiliari mediante un trasformatore esterno utilizzando i morsetti 1 e 2 posti nella morsettiera del quadro. Per impostare correttamente l’alimentazione dei circuiti ausiliari occorre, come mostrato nello schema di seguito riportato, collegare un’estremità dell’avvolgimento secondario del trasformatore a terra e ad esso devono fare capo direttamente un morsetto, delle bobine, dei relè e dei contattori (in pratica, il comune di tutte le bobine di comando componenti il circuito); in tal modo, ogni guasto a terra che si dovesse verificare nel tratto di circuito compreso fra il secondo morsetto della bobina e l’altra estremità del secondario, verrebbe ricondotto a cortocircuito e, come tale, rilevato dalla protezione di massima corrente (in questo caso dai fusibili). Nel contempo la bobina non potrebbe eccitarsi, poiché entrambi i suoi capi verrebbero ad assumere il potenziale di terra.
I guasti verso terra, rappresentati nel precedente schema, mostrano alcune situazioni che possono diventare pericolose se non si adotta la soluzione circuitale proposta precedentemente (si immagini, ad esempio, che i contattori K1, K2 e K3 alimentino dei motori elettrici che azionano presse, nastri trasportatori o macchine utensili).
Fig. 19 - Esempio di circuito ausiliario alimentato attraverso un trasformatore, con un morsetto del secondario collegato a terra ed ai comuni delle bobine. Esempi di guasti verso terra (clicca per ingrandire)
Nel primo tipo di guasto (caso A), dove troviamo un contatto in serie tra la bobina del contattore K1 e il conduttore di alimentazione collegato a terra, l’eventuale intervento del relè termico F2, che provoca l’apertura del contatto NC (95-96), diventerebbe inefficace, in quanto il guasto, in pratica, metterebbe in cortocircuito il contatto stesso, vanificando l’azione protettiva sul motore del relè termico. Questo tipo di collegamento perciò, se non in casi particolari, non deve essere mai eseguito. Nel secondo tipo di guasto (caso B) si ha invece il cortocircuito del pulsante di arresto S3, che impedirebbe la diseccitazione del contattore K2, anche se il pulsante venisse azionato. Infine con il terzo tipo di guasto (caso C) si ottiene l’effetto di eccitare, senza premere il pulsante S6 di marcia, il contattore K3; anche in questo caso si hanno imprevedibili e pericolose conseguenze per il personale addetto e per il macchinario. In realtà sono ammesse alcune eccezioni, in particolare è possibile collegare i contatti dei dispositivi di protezione (per esempio, relè termico) fra l’estremo connesso al circuito di protezione equipotenziale e le bobine quando i conduttori fra questi contatti e le bobine dei dispositivi di comando, su cui operano i contatti dei relè, sono all’interno del medesimo involucro di comando e la connessione è così corta e di un particolare tipo da rendere improbabile un guasto a terra. Per quanto riguarda la stesura degli schemi funzionali si è fatto riferimento alle raccomandazioni delle norme CEI riportate nel primo capitolo.
Si consiglia, oltre alla lettura del testo che descrive il funzionamento dell’impianto, di leggere attentamente i commenti riportati nella parte superiore di ogni schema funzionale; ogni commento, infatti, descrive sinteticamente la funzione svolta da ogni singola parte di schema. Quando è stato possibile, i gruppi funzionali e gli altri elementi sono stati disposti in modo da evidenziare chiaramente la sequenza delle operazioni (da sinistra verso destra o dall’alto verso il basso) o il flusso dei segnali. Nella rappresentazione dei circuiti sono stati adottati alcuni accorgimenti, anche di ordine estetico, per migliorare la chiarezza negli schemi. Si è cercato, inoltre, di adottare una disposizione dello schema che faciliti l’esecuzione delle prove di funzionamento e la localizzazione dei guasti (per esempio, numerazione dei cavi e dei morsetti). Questo modo di impostare la documentazione tecnica ritornerà utile anche per una corretta stesura dei programmi per i controllori logici programmabili (PLC) e il collegamento degli stessi con i dispositivi di ingresso e di uscita (pulsanti, selettori, contattori, elettrovalvole, ecc.).

