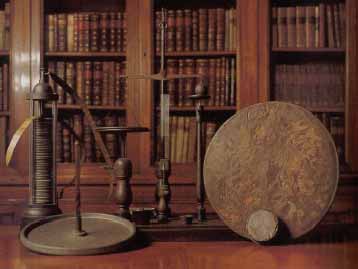Le batterie al piombo (tensione nominale 2 V), nelle loro varianti piombo-acido, piombo-gel, ermetiche, piombo-calcio..., costituiscono la più vecchia e diffusa tecnologia di accumulatori. Hanno un costo piuttosto limitato e un’energia specifica riferita al volume di poco inferiore agli accumulatori al nichel-cadmio, mentre l’energia specifica riferita al peso non è delle migliori, come ben si sa.
Le batterie di questo tipo utilizzate in ambiente industriale variano come capacità da 50 A/h a 5000 A/h.
La loro autoscarica è inferiore allo 0,1 % al giorno a temperatura ambiente e non risentono di nessun fenomeno di memoria, nonostante ripetuti brevi utilizzi e continue scariche e ricariche alle quali possono essere sottoposte.
D’altra parte lo sviluppo di idrogeno, soprattutto durante la fase finale della carica, che può portare ad un pericolo di esplosione in ambiente chiuso, e la presenza del piombo che deve essere smaltito secondo precise modalità, sono i maggiori svantaggi (oltre al peso) che questi accumulatori si portano addosso.
Le applicazioni vanno dal settore automobilistico agli Ups, dai carrelli elevatori ai più svariati utilizzi industriali. Per queste batterie vanno adottati dei programmi di manutenzione (in maniera limitata anche per il tipo ermetico) che consistono nella verifica della densità del liquido, nell’ispezione visiva delle interconnessioni fra elementi in serie, nell’aggiunta di elettrolito o acqua, se necessario. Il ciclo di vita non è elevatissimo, con una durata che dopo i 200 cicli risulta avere una capacità inferiore all’80% del valore nominale.
Al nichel-cadmio
Penalizzate dalla presenza del cadmio, elemento tossico, queste batterie (tensione nominale 1,2 V) hanno però notevoli vantaggi, a partire da un rapporto costi/prestazioni elevato, unito ad un elevato numero di cicli di carica possibili (da 500 a 1000).
Di contro, occorre dire che sono soggette al famigerato effetto memoria, cioè dopo un certo numero di scariche e ricariche parziali, la batteria al nichel-cadmio non è in grado di fornire la capacità completa, se non dopo due o tre cicli di carica/scarica completi. L’autoscarica è di circa lo 0,3% al giorno, a temperatura ambiente.
Gli utilizzi sono diversi e vanno dai telefoni cellulari alle macchine fotografiche e a tutte quelle applicazioni combinate spina-batteria (rasoi elettrici, registratori, telecamere, radioricevitori...).
Al nichel-idruro metallico
Gli accumulatori al nichel-idruri metallici hanno una capacità più elevata di quella degli accumulatori al cadmio (circa doppia).
La durata di vita è simile alle nichel-cadmio (500-100 cicli di carica/scarica), ma l’effetto memoria è quasi completamente assente, anche se occorre fare attenzione, durante il processo di carica, a non superare i 50 °C, pena il danneggiamento delle batterie stesse: per questo motivo vengono utilizzati caricatori appositi.
Gli svantaggi rispetto agli accumulatori al cadmio sono rappresentati da una minore energia specifica e da un più marcato processo di autoscarica. Sul lato ambientale non c’è ovviamente confronto, a vantaggio degli accumulatori NiMH che sono ecologicamente molto più accettabili, non avendo metalli pesanti come il cadmio.
Purtroppo il costo è attualmente del 25% circa superiore rispetto a quello di un’analoga batteria al NiCd. Le applicazioni sono pressoché infinite e si sovrappongono quasi perfettamente a quelle delle batterie sorelle al NiCd: computer portatili, cellulari, sistemi audiovisivi, applicazioni domestiche, periferiche industriali...
Al litio
Sfruttano, come le pile al litio, l’alto potenziale elettrochimico del litio e il suo basso peso specifico (tensione nominale 3 V).
Altri vantaggi consistono in un’elevata energia specifica (sia di massa sia di volume), in una lunga durata in cicli e in una minima autoscarica. Infine, con gli accumulatori al litio non si corre il rischio di contaminare l’ambiente (a differenza di quanto avviene con gli accumulatori al cadmio). I tempi di ricarica sono molto brevi e - anche se necessitano di un caricatore particolare. Il loro costo (400-600 € kWh) non aiuta la loro diffusione sul mercato, che pure è in espansione particolarmente per pc portatili, telefoni cellulari e videoregistratori.
Celle a combustibile
Una cella a combustibile è un dispositivo elettrochimico che converte direttamente l’energia di un combustibile in elettricità e calore senza passare attraverso cicli termici.
Funziona quindi in modo analogo a una batteria, in quanto produce energia elettrica attraverso un processo elettrochimico, ma consuma sostanze provenienti dall’esterno ed è quindi in grado di funzionare senza interruzioni, finché al sistema vengono forniti combustibile e ossidante.
Ogni cella è composta da due elettrodi in materiale poroso, separati da un elettrolita. Gli elettrodi fungono da siti catalitici per le reazioni di cella che consumano fondamentalmente idrogeno ed ossigeno, con produzione di acqua e passaggio di corrente elettrica nel circuito esterno.
La trasformazione elettrochimica è accompagnata da produzione di calore, che è necessario estrarre per mantenere costante la temperatura di funzionamento della cella.
Le singole celle (caratterizzate da tensioni comprese da mezzo volt a un volt) vengono collegate in serie in modo da ricavare una tensione complessiva del valore desiderato formando il cosiddetto stack (pila). A differenza dei combustibili fossili, l’idrogeno provoca poche emissioni inquinanti, anche se, a contatto con l’ossigeno, è altamente esplosivo.
L’idrogeno, inoltre, può essere immagazzinato allo stato gassoso, liquido o legato chimicamente.
Le celle a combustibile possono essere classificate in base al tipo di elettrolita utilizzato: celle a combustibile ad elettrolita polimerico, alcaline, ad acido fosforico, a carbonati fusi, ad ossidi solidi.
Le applicazioni principali vanno dalla trazione per veicoli, all’alimentazione di reti elettriche e sistemi di emergenza. Interessantissime sono le celle a combustibile miniaturizzate per impieghi portatili (telefoni cellulari, computer portatili) da utilizzare in alternativa, per esempio, ad una batteria Ni-Cd e senza bisogno di ricarica, in quanto basta rimpiazzare in modo rapido il combustibile. Un altro vantaggio potenziale delle celle a combustibile è dato dai costi.
Una batteria Ni-Cd da 20 W dura un’ora e costa 15 €.
Una batteria ricaricabile al litio fornisce la stessa potenza per circa tre ore, ma costa almeno quattro volte di più. Per contro, una cella a combustibile alimentata a metanolo potrebbe durare 30 ore e costare appena 1,5-4 euro. Ricordiamo che della produzione di energia elettrica attraverso le celle a combustibile si occupa anche la nuova guida Cei 64-57.
Supercondensatori
I supercondensatori non rientrano nella categoria dei dispositivi che convertono energia chimica in energia elettrica, ma il loro obiettivo è sostanzialmente lo stesso. Tutti sappiamo che un condensatore carico è come una sorta di batteria che però, a causa dei bassi valori di capacità, si scarica in tempi brevissimi ed oltretutto con legge esponenziale.
Un supercondensatore moltiplica questa possibilità, assumendo valori di capacità nell’ordine delle centinaia o addirittura migliaia di Farad, permettendone così l’uso come riserva per applicazioni di piccola potenza.
I vantaggi di questa tecnologia sono diversi: i tempi di carica sono rapidissimi (circa 10 secondi), anche se ovviamente anche i tempi di autoscarica (scarica a circuito aperto) sono molto più rapidi rispetto a quelli di una batteria tradizionale (50% del valore dopo un mese, contro il 90% del valore di una qualunque batteria al nichel).
Un altro notevole vantaggio è dato dal tempo di vita; infatti un supercondensatore può essere caricato e scaricato un numero praticamente illimitato di volte, in quanto tale processo non implica, o quasi, reazioni chimiche. Inoltre anche l’effetto memoria è totalmente assente e non ci sono nemmeno problemi di eventuali sovraccarichi in quanto, come si sa dalla natura dei condensatori, una volta terminato il processo di carica non viene più accettata energia.
Poiché possono fornire elevate potenze elettriche per brevi periodi di tempo, mentre i generatori primari sono più adatti a fornire correnti elettriche per tempi lunghi e intensità costante, i supercondensatori possono essere quindi utilizzati vantaggiosamente, insieme a batterie, nei veicoli elettrici, nelle ricetrasmittenti, nelle videocamere, negli stereo, negli Ups per i quali si verificano durante il funzionamento richieste di potenza variabili.
In particolare risultati del Centro Ricerche Fiat di Orbassano, ottenuti allestendo un’autovettura con supercondensatori a elettrodi di carbone, hanno evidenziato un positivo effetto sulle batterie di servizio qualora abbinate ai supercondensatori: viene richiesta una capacità ridotta della batteria di servizio con conseguente riduzione di peso (oltre il 30%) e riduzione di materiali inquinanti sia a bordo del veicolo sia allo smaltimento a fine vita dell’accumulatore stesso.