Carrello
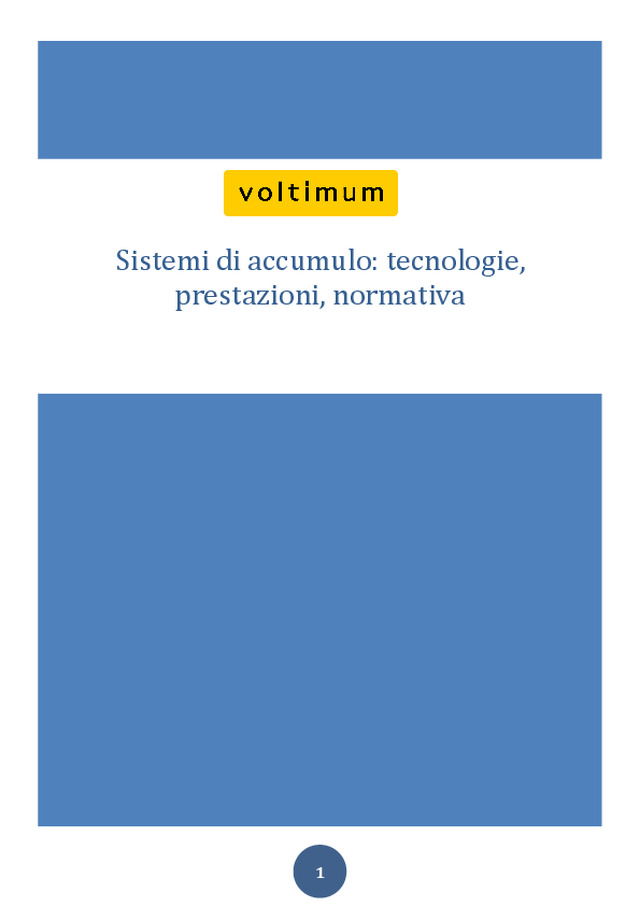
Sistemi di accumulo: tecnologie, prestazioni, normativa
In questa nuova guida tecnica affronteremo il tema dei sistemi di accumulo. Parleremo sia delle classiche tecnologie di accumulo elettrochimico che di nuove tecnologie innovative; dei parametri prestazionali e delle normative vigenti.
1 Sistemi di accumulo: tecnologie, prestazioni, normativa
2 Sommario Sistemi di accumulo: tecnologie, prestazioni, normativa ........................................................................... 3 Tecnologie di accumulo elettrochimico ........................................................................................................ 3 Accumulatore al piombo ................................................................................................................................ 4 Accumulatore litio/ioni .................................................................................................................................. 4 Accumulatore al nichel/cadmio .................................................................................................................. 5 Accumulatore nichel/metalli idruri .......................................................................................................... 5 Batteria Redox a flusso di elettrolita ......................................................................................................... 5 Batterie ad alta temperatura ........................................................................................................................ 6 Altre tipologie di accumulo energetico ......................................................................................................... 6 Accumulo di energia potenziale .................................................................................................................. 6 Accumulo di energia meccanica .................................................................................................................. 6 Accumulo di energia elettrostatica ............................................................................................................ 7 Tecnologie innovative di accumulo ........................................................................................................... 7 Parametri prestazionali ...................................................................................................................................... 7 Il contesto normativo ........................................................................................................................................... 9 Alcune definizioni ........................................................................................................................................... 10 Possibili configurazioni impiantistiche .................................................................................................. 10 Condizioni per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE ................ 13 Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di accumulo ................................................. 13 Regole di connessione alla rete ................................................................................................................. 14
3 Sistemi di accumulo: tecnologie, prestazioni, normativa Il crescente interesse verso le tecnologie di accumulo dell’energia elettrica è direttamente legato all’evoluzione avvenuta nel settore elettrico negli ultimi 10 anni, caratterizzata dalla diffusione massiccia di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Il concretizzarsi della transizione verso un sistema energetico sempre più decentrato (cosiddetta “generazione distribuita”), unitamente alla riduzione dei costi di produzione degli accumulatori litio/ioni ottenuta grazie al boom della mobilità elettrica, stanno gettando le basi per la diffusione di sistemi di accumulo domestico di energia elettrica davvero performanti e convenienti, anche in assenza di incentivi. Trattare di un argomento potenzialmente vastissimo quale quello degli accumuli, significa non soltanto doversi confrontare con le diverse opzioni tecnologiche oggi disponibili sul mercato, tentando per quanto possibile anche un confronto sul piano delle prestazioni, dei costi e dei rendimenti. Risulta infatti indispensabile conoscere il quadro normativo e regolatorio sugli accumuli, ad oggi già piuttosto complesso anche se la prima disposizione in materia risale soltanto alla fine del 2014. Tecnologie di accumulo elettrochimico Quando si parla di tecnologie di accumulo elettrico, in relazione a contesti e utilizzi residenziali, commerciali, industriali o comunque per applicazioni di piccola-media taglia, si fa quasi sempre riferimento al solo accumulo di tipo elettrochimico. Si tratta in poche parole dell’accumulo di elettricità realizzato mediante “batterie” o “pile” (più o meno innovative dal punto di vista tecnologico), che grazie alle loro caratteristiche di affidabilità ed economicità rappresentano la quasi totalità dei sistemi di accumulo abbinati a impianti di generazione distribuita, tipicamente fotovoltaico. Ci limiteremo quindi soltanto a citare l’esistenza delle altre tipologie di accumulo, concentrando invece tutta l’attenzione sull’accumulo elettrochimico. Un generatore elettrochimico è un dispositivo che converte energia elettrica in energia chimica sfruttando reazioni di ossido-riduzione, ovvero reazioni chimiche in cui si ha la perdita e l’acquisto di elettroni da parte delle specie reagenti. In un accumulatore elettrochimico tale reazione di ossido-riduzione è reversibile: può quindi essere ricaricato applicando un campo elettrico dall’esterno. Gli accumulatori elettrochimici sono composti da collegamenti, in serie o in parallelo, di celle elementari. La struttura base di una cella è formata da due semicelle, ciascuna composta da un elettrodo metallico immerso in una soluzione elettrolitica. Un setto poroso posto tra le due semicelle consente il passaggio degli ioni, necessario per ottenere il bilanciamento delle cariche, impedendo il passaggio degli elettroni e il mescolamento delle soluzioni. In questo modo tra i due
4 elettrodi si genera una differenza di potenziale, che è alla base del meccanismo di funzionamento delle batterie. Fonte: larapedia.com La principale modalità di classificazione delle tecnologie di accumulo elettrochimico disponibili è in funzione della natura elettrochimica delle sostanze reagenti. Accumulatore al piombo Si tratta della tecnologia più diffusa (oltre 130 GWh installati globalmente), matura ed affidabile, con un larghissimo impiego in applicazioni stazionarie quali UPS, alimentazioni di emergenza in centrali o sottostazioni elettriche, nelle telecomunicazioni e nei trasporti, come batteria di avviamento. Per minimizzarne l’ingombro, si realizzano normalmente monoblocchi da 6 o 12 celle elemenari, con tensione nominale di 12-24 Volt. Le materie prime utilizzate (piombo, solfato di piombo, acido solforico) sono poco costose e completamente riciclabili. Nonostante un discreto rendimento energetico, compreso tra il 70% e l’85%, presentano una scarsa durata di vita e una bassa energia specifica, non superiore a 40 Wh/kg, che non ne consente l’impiego per la propulsione di veicoli elettrici. Fonte: ultracell.it Accumulatore litio/ioni Si tratta della tecnologia più promettente e versatile, oramai diffusa in tutti i campi, dall’alimentazione dei dispositivi elettronici portatili alla propulsione dei veicoli elettrici e alle applicazioni a supporto del sistema elettrico. Ne esistono di diverse tipologie, che si differenziano sulla base dei materiali che compongono gli elettrodi e l’elettrolita. L’anodo delle celle (le quali possono presentare dimensioni e geometrie diverse: cilindrica, prismatica, polimerica, ecc.) è
5 generalmente costituito da grafite litiata, mentre il catodo da un ossido litiato di un metallo di transizione, come ferro fosfato, ossido di manganese, ecc. L’elettrolita, di tipo organico, può essere liquido o polimerico; il litio, intercalato negli elttrodi in forma ionica, è presente in percentuale ridotta, inferiore al 2%. In ogni caso al di là delle possibili diverse sottocategorie, gli accumulatori litio-ioni sono accomunati dal fatto di presentare caratteristiche prestazionali molto interessanti, quali l’elevata resa specifica, la lunga vita utile e un rendimento energetico che può arrivare quasi al 100%. Condizioni di sovraccarico elettrico e/o termico possono determinare situazioni di pericolo; è indispensabile quindi la presenza di un sistema di bilanciamento delle tensioni di cella e di un BMS (Battery Management System) che monitori le grandezze di cella e di batteria e intervenga in caso di condizioni a rischio. Fonte: smartbattery.com Accumulatore al nichel/cadmio Dopo piombio e litio, la batteria al nichel/cadmio è la terza tecnologia di accumulo al mondo per volume di vendite. Si tratta di una tecnologia con numerose applicazioni militari e industriali, come ad esempio nella trazione ferroviaria e più in generale dove è richiesto un sistema affidabile e robusto, capace di lavorare in potenza e in condizioni ambientali estreme. I costi sono molto elevati e non è previsto per il futuro un impiego di questa tecnologia al di fuori degli attuali utilizzi. Presenta inoltre alcune possibili criticità ambientali, dovute alla presenza del cadmio. Accumulatore nichel/metalli idruri E’ il risultato dell’unione tra la tecnologia di accumulo di idrogeno e quella al nichel/cadmio, di cui condivide le caratteristiche eccezion fatta per il minore impatto ambientale. Anche in questo caso, il costo elevato ne limita la diffusione al di fuori di specifiche applicazioni. Viene impiegata anche in applicazioni elettroniche portatili di piccola taglia e per la trazione dei veicoli elettrici, ma in questi settori è stata quasi completamente sostituita dalla più efficiente tecnologia litio/ioni. Batteria Redox a flusso di elettrolita Questa batteria di tipo ricaricabile ha la caratteristica principale di avere gli elettroliti liquidi stoccati esternamente, generalmente in vasche o serbatoi, e pompati attraverso le celle. Questo consente di realizzare un completo disaccoppiamento tra la potenza, dipendente dalle dimensioni dello stack (la parte della batteria che contiene le celle elementari elettricamente collegate in serie), e l’energia, dipendente dalle dimensioni dei serbatoi esterni. Ne esistono di diverse tipologie, a seconda della coppia elettrochimica utilizzata (zinco/bromo, ferro/cromo, ecc.). Adatta alle applicazioni di grande taglia, nell’ordine del megawattora, tale tecnologia presenta alcuni
6 svantaggi in termini di oneri economici aggiuntivi, dovuti alla presenza del circuito idraulico e di organi in movimento. Una interessante sottospecie di batteria Redox è quella al Vanadio, che impiega un solo elemento elettroattivo (il vanadio, appunto) anziché due. Ad alcune caratteristiche prestazionali negative, quali una bassa energia specifica (max 25 Wh/kg) e un limitato range di temperatura di funzionamento (0 ÷ 40 °C), se ne affiancano altre positive come una lunga vita attesa (oltre 10.000 cicli di carica/scarica) e rapidissimi tempi di risposta alle variazioni di carico. Batterie ad alta temperatura Hanno una struttura completamente diversa dalle altre batterie: gli elettrodi infatti sono allo stato fuso e l’elettrolita è un materiale ceramico (β”-allumina). L’alta temperatura di lavoro delle batterie (compresa tra 250 e 350 °C) è indispensabile per portare gli elettrodi allo stato fuso e aumentare la conducibilità dell’elettrolita. Sono batterie realizzate sotto forma di moduli che assemblano un certo numero di celle, completi di BMS (Battery Management System) e ausiliari. Tali moduli presentano un’efficace coibentazione termica, in grado anche di assicurare buone prestazioni indipendentemente dalla struttura esterna. L’elettrolita in materiale ceramico rappresenta un punto debole di queste batterie, poiché un’eventuale rottura metterebbe in contatto gli elettrodi. Sono disponibili in due principali tecnologie, sodio/zolfo (NAS) e sodio/cloruro di nichel. L’abbondanza e la non tossicità del sodio rendono le batterie NAS commercialmente molto interessanti, anche in termini in densità di potenza e di energia. Alcuni problemi di gestione e di sicurezza sono invece imputabili alla necessità di operare ad alte temperature per tenere il sodio in forma liquida. Nonostante questo, le batterie NAS rimangono fino ad oggi le più usate per applicazioni stazionarie a supporto della rete e per l’integrazione con impianti eolici e fotovoltaici. Rispetto alla NAS, di cui costituisce un’evoluzione, la batteria sodio/cloruro di nichel, presenta una maggiore sicurezza intrinseca e anche possibili applicazioni future nel campo della mobilità. Altre tipologie di accumulo energetico Come già accennato, ci limitiamo in queste sede a fare soltanto un breve accenno alle tecnologie di accumulo di tipo non elettrochimico. Accumulo di energia potenziale Ci si riferisce ai tradizionali sistemi di pompaggio idroelettrico che, con una potenza globale di circa 125 GW, rappresentano oltre il 98% della capacità di accumulo oggi complessivamente installata. Il funzionamento di questi sistemi è piuttosto semplice: durante i periodi di bassa domanda di energia, nell’impianto di pompaggio l’acqua viene trasferita, tramite pompe, da un serbatoio inferiore ad uno superiore, immagazzinando in questo modo l’energia sotto forma di energia potenziale. Nei periodi di elevata richiesta, l’acqua dal serbatoio superiore viene rilasciata in quello inferiore, azionando le turbine e generando così energia elettrica. Ideali per gestire grandi potenze (da qualche decina di MW fino a oltre 1.000 MW), tali impianti sono molto importanti non solo per gestire i picchi di richiesta ma anche per regolare la frequenza di rete. Accumulo di energia meccanica Comprende due tecnologie tra loro diverse: volani e CAES. La batteria a volano è un dispositivo che immagazzina energia sotto forma di energia cinetica rotazionale, grazie alla rotazione ad altissime velocità di una massa cilindrica da parte di un motore elettrico, che ne assorbe gli
7 eccessi di produzione. Attriti e perdite areodinamiche rappresentano oggi alcuni dei principali ostacoli alla loro diffusione. La potenza media di questi dispositivi è sui 10-20 kW, mentre l’energia accumulabile è di qualche decina di kWh. I sistemi CAES(Compressed Air Energy Storage), di immagazzinamento dell’aria compressa, sono una delle tecnologie di accumulo più studiate e potenzialmente interessanti, specie per gli accumuli di grossa taglia. In un tipico impianto CAES, l’aria compressa accumulata normalmente all’interno in un serbatoio geologico, viene è fatta espandere all’interno di una turbina a gas (collegata a una generatore), dopo essere stata riscaldata mediante la combustione di gas naturale. Negli ultimi anni la ricerca si sta focalizzando sul CAES “adiabatico”, realizzato senza l’impiego di combustibili fossili. Accumulo di energia elettrostatica I sistemi elettrostatici accumulano energia elettrica sotto forma di carica elettrostatica in un condensatore, un dispositivo composto da due materiali (normalmente piastre metalliche) separati da un dielettrico. La ricerca è concentrata sui “supercondensatori”: si tratta di una versione tecnologicamente più avanzata di condensatore, in cui viene massimizzata l’area superficiale disponibile per l’accumulo delle cariche elettriche e si utilizzano elettrodi composti da strati di carbonio oppure filamenti metallici, perfusi da liquidi che fungono da dielettrici. Sono dispositivi in grado di fornire valori di potenza elevata in rapidissimo tempo, con autonomie molto brevi e per un numero elevatissimo di cicli di carica e scarica. Caratteristiche che li rendono interessanti per le applicazioni nel campo della trazione elettrica, nelle applicazioni di potenza per impianti fissi e in accoppiamento con altri tipi di accumulatori elettrochimici, per aumentarne potenza e vita utile. Tecnologie innovative di accumulo Si tratta di tecnologie ancora a livello prototipale o comunque con scarsissima diffusione, fattori che non ne consentono ancora una valutazione oggettiva su costi, caratteristiche e prestazioni. In molti casi si tratta di promettenti evoluzioni di tecnologie di accumulo già consolidate. Tra le tecnologie maggiormente innovative, vanno almeno citate le batterie metallo-aria, i magneti super-conduttori (SMES), i supercondensatori basati sul grafene, lo stoccaggio marino di aria compressa e il pompaggio di acqua di mare. Parametri prestazionali Il corretto dimensionamento di un sistema di accumulo e un confronto tecnico-economico tra le diverse tecnologie di accumulo possono essere effettuati soltanto a partire dalla conoscenza e dall’analisi di alcuni parametri prestazionali, tra cui: • Capacità (Ah): Quantità di carica elettrica estraibile dalla batteria durante la scarica, fino al raggiungimento della condizione di fine scarica. Il suo valore dipende da molti fattori, tra cui la corrente di scarica e la temperatura di lavoro. La capacità nominale è riferita a un particolare regime di scarica e di temperatura. • Forza elettromotrice (V): Differenza di potenziale tra i due elettrodi a circuito esterno aperto, con valore variabile a seconda dello stato di carica. La tensione nominale è un valore rappresentativo della tensione ai morsetti durante la scarica.
8 • Stato di carica (State of charge – SOC): Quantità di carica presente nell’accumulatore rapportata a un valore, molto spesso coincidente con la capacità nominale, espressa in percentuale. • Profondità di scarica (Depht of discharge – DOD): Quantità di carica erogata dall’accumulatore rapportata a un valore, molto spesso coincidente con la capacità nominale, espressa in percentuale. • Rendimento amperorametrico (%): Rapporto tra la quantità di carica estratta dal sistema di accumulo durante una scarica e la quantità necessaria per riportare il sistema nello stato di carica iniziale. Soltanto per alcuni accumulatori elettrochimici (sodio/zolfo, sodio/cloruro di nichel, litio/ioni) tale parametro ha valore unitario; per molte altre tipologie di accumulo, tra cui il piombo, tale parametro ha un valore incostante e inferiore all’unità, a causa di reazioni parassite che avvengono durante la ricarica. • Energia nominale (Wh): Quantità di energia che si può estrarre dal sistema durante la scarica, partendo da una condizione di piena carica fino alla scarica completa. L’energia nominale è data dal prodotto della capacità per la tensione dell’accumulatore. Anche questo parametro dipende dal regime di lavoro e dalla temperatura ambiente. • Potenza (Wh/l): La potenza erogabile da un accumulatore non può essere definita univocamente, poiché dipende dal carico applicato. Può però essere individuata una potenza nominale, ovvero la potenza corrispondente al regime di scarica sufficientemente rappresentativo del regime di lavoro cui la batteria è destinata. E’ utile inoltre conoscere la potenza di picco ai 30 secondi, ovvero la potenza che l’accumulatore è in grado di sostenere per 30 secondi con un valore del DoD dell’80%, cioè a batteria quasi scarica. • Energia specifica (Wh/kg) e densità di energia (Wh/l): Energia rapportata al peso/al volume dell’accumulatore. • Potenza specifica (W/kg) e densità di potenza (W/l): Potenza rapportata al peso/al volume dell’accumulatore. • Rendimento energetico (%): Rapporto tra l’energia estratta dal sistema di accumulo durante una scarica a una data potenza e l’energia spesa per riportare il sistema nello stato di carica iniziale. • Tempo di risposta: Tempo che impiega il sistema a rispondere ad una variazione di carico. • Livello di sicurezza intrinseca: Definisce quanto una tecnologia è sicura, a prescindere dall’impiego di sistemi di sicurezza. • Tempo di vita (cicli): Numero di cicli di scarica e ricarica che il sistema è in grado di completare in determinate condizioni di lavoro, prima che le sue prestazioni scendano sotto un limite minimo. • Tempo di vita (anni): Numero di anni nei quali che il sistema è in grado di operare in determinate condizioni di lavoro, prima che le sue prestazioni scendano sotto un limite minimo. Tale parametro dipende fortemente dalle modalità di lavoro e si riduce drasticamente se è sottoposto ad una gestione non corretta e se l’accumulatore lavora ad una temperatura alta.
9 • Costo di investimento e costi operativi: Prezzo di acquisto del sistema e costi di esercizio e manutenzione • Reazioni parassite: Le reazioni “parassite” sono reazioni “secondarie” che ostacolano il corretto funzionamento della cella elettrochimica. Tali reazioni sono anche alla base del fenomeno dell’autoscarica, ovvero la scarica che avviene quando l’accumulatore è a riposo e che nel tempo portano alla scarica completa. Il contesto normativo Dal punto di vista normativo e regolatorio, la materia degli accumuli ha una storia molto recente. Infatti è stata la delibera 574/2014/R/eel del 20 novembre 2014 dell’Autorità per l’energia a dare le prime regole per l’integrazione dei sistemi di accumulo di energia nel sistema elettrico nazionale. Ulteriori disposizioni sull'installazione e l'utilizzo dei sistemi di accumulo nonché sull'applicazione delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 sono arrivate con delibera n. 642/2014/R/EEL del 18 dicembre 2014, successivamente modificata dalla delibera n. 360/2015/R/EEL del 16 luglio 2015. In data 8 aprile 2015, il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha pubblicato le "Regole Tecniche per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale". Tale documento - che è stato rivisto e aggiornato in data 15 giugno 2017 - struttura in maniera organica le modalità di gestione dei sistemi di accumulo integrati con gli impianti di produzione di energia elettrica gestiti dal GSE. Rispetto alla prima edizione, i contenuti della versione attuale delle Regole Tecniche recepiscono le più recenti disposizioni regolatorie, nonché gli aggiornamenti delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 effettuati dal Comitato Elettrotecnico Italiano. Le Regole Tecniche illustrano: • il contesto normativo e regolatorio di riferimento; • gli schemi di connessione alla Rete dei sistemi di accumulo così come definiti dal CEI; • i requisiti da rispettare per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile, che accedono agli incentivi o alle garanzie di origine ovvero, nell’ambito del ritiro dedicato, ai prezzi minimi garantiti; • i requisiti per il mantenimento degli incentivi o benefici già riconosciuti agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili nei casi in cui vengano installati sistemi di accumulo; • le modalità di gestione delle comunicazioni relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione gestiti dal GSE; • gli algoritmi utilizzati dal GSE per la quantificazione dell’energia elettrica prodotta o immessa in rete e le modalità di erogazione, sia in acconto che a conguaglio, degli incentivi ovvero dei benefici riconosciuti agli impianti di produzione, a seguito dell’installazione di sistemi di accumulo.
10 Alcune definizioni Vediamo nel dettaglio alcune importanti nuove definizioni relative ai sistemi di accumulo, introdotte dalla delibera n. 574/2014/R/EEL. Il sistema di accumulo è definito come “ un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità”. A seconda della posizione in cui è installato, il sistema di accumulo si distingue in: • Sistema di accumulo lato produzione: “è un sistema di accumulo installato, o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell'inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l'impianto di produzione e il misuratore dell'energia elettrica prodotta”; • Sistema di accumulo post produzione: “è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell'energia elettrica prodotta e il misuratore dell'energia elettrica prelevata e immessa”. A seconda invece della capacità di assorbire elettricità, il sistema si distingue in: • Sistema di accumulo bidirezionale: “è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall'impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi”; • Sistema di accumulo monodirezionale: “è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall'impianto di produzione”. Possibili configurazioni impiantistiche Partendo dalle definizioni contenute nella delibera e secondo quanto previsto dalle Varianti alla Norma CEI 0-21 e alla Norma CEI 0-16 e ripreso nelle Regole Tecniche del GSE, per i sistemi di accumulo sono possibili tre diverse configurazioni impiantistiche. • Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale
11 Fonte: Regole Tecniche GSE • Configurazione 2: sistema di accumulo lato produzione bidirezionale Integrato in corrente continua Fonte: Regole Tecniche GSE
12 Integrato in corrente alternata Fonte: Regole Tecniche GSE • Configurazione 3: sistema di accumulo post produzione bidirezionale Fonte: Regole Tecniche GSE
13 Condizioni per l’installazione di sistemi di accumulo su impianti gestiti dal GSE Ai fini dell’accesso o del mantenimento degli incentivi, nonché dei benefici previsti dai decreti e dalle delibere di riferimento, i sistemi di accumulo devono essere integrati nel sistema elettrico in accordo alle seguenti condizioni: • rispetto delle disposizioni per l’erogazione del servizio di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento dell’energia elettrica previste dalla delibera 574/2014/R/eel, e delle norme CEI di riferimento; • rispetto dei requisiti tecnici dei dispositivi elettronici individuati dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 in vigore, rispettivamente per le connessioni in bassa e media tensione. La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata attraverso valida certificazione di conformità alle suddette norme; • corretta installazione ed avvenuta attivazione delle idonee apparecchiature di misura atte a quantificare l’energia prodotta, immessa in rete nonché quella assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo, come certificato dai gestori di rete. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni inerenti l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo: • nei casi di sistemi di accumulo lato produzione: se le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sono caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature stesse deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi al Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME); • nei casi di sistemi di accumulo post-produzione: per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionale e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi al Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME). Comunicazione al GSE dell’installazione di sistemi di accumulo Le modalità di comunicazione al GSE relative all'installazione di sistemi di accumulo e la documentazione da allegare sono dettagliate nelle "Regole Tecniche per l’attuazione delle disposizioni sull’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale". La comunicazione di avvenuta installazione deve resa dal soggetto responsabile dell’impianto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base di uno dei modelli allegati
14 alle Regole Tecniche e deve essere inviata al GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio del sistema di accumulo. Nei casi di installazioni che adottano soluzioni realizzative tecnologicamente avanzate e innovative, quali ad esempio nuovi brevetti industriali, è facoltà del soggetto responsabile presentare al GSE una richiesta di valutazione preliminare della conformità del progetto alla regolazione di settore, ai fini dei possibili effetti dell’intervento che intende realizzare sugli incentivi, sulle garanzie di origine ovvero sui prezzi minimi garantiti di cui beneficia l’impianto di produzione presso cui è installato il sistema di accumulo. La richiesta di valutazione preliminare dell’intervento diventa invece obbligatoria nel caso di configurazioni: • "complesse", caratterizzate da uno o più sistemi di accumuli installati presso impianti di produzione che condividono il medesimo punto di connessione e che beneficiano di regimi di incentivazione anche differenti, ovvero dei prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato; • "miste" caratterizzate da più sistemi di accumulo installati presso impianti di produzione e posizionati in accordo a diversi schemi di configurazioni CEI (ad esempio, un sistema di accumulo installato in configurazione 2 ed il secondo sistema di accumulo installato in configurazione 3). Non è ancora stato implementato il sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, pertanto le comunicazioni con il GSE devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata oppure posta raccomandata A/R. Regole di connessione alla rete Le regole tecniche, procedurali ed economiche per la connessione alla rete elettrica da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento sono contenute nella delibera ARG/elt 99/08 - Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA). Poiché un sistema di accumulo è, dal punto di vista normativo e regolatorio, equiparato ad una unità di produzione, l’Autorità per l’energia ha indicato le modalità con cui il TICA si applica anche agli accumuli. Richiedere la connessione alla rete elettrica di un sistema di accumulo si configura come: • una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, qualora l'accumulo venga predisposto su impianto di produzione esistente, già connesso e attivato; • una richiesta di nuova connessione, qualora l'accumulo non sia integrato con un impianto di produzione esistente, già connesso e attivato. Per le regole e l’iter di connessione, occorre fare riferimento in primo luogo ai due articoli della Parte V, Titolo IV del TICA, recante "Disposizioni per la connessione alla rete dei sistemi di accumulo." Da una parte, l’articolo 38-bis stabilisce che – per quanto riguarda le modalità di connessione alla rete – un sistema di accumulo "è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un
15 impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'articolo 38-ter." Dall'altra parte, il successivo articolo (articolo 38-ter) prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 38-bis, fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento." In altre parole, ciò significa che attualmente – e in via transitoria - le condizioni per connettere alla rete un sistema di accumulo sono le medesime previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, che hanno regole e iter pressoché analoghi a quelli previsti per gli impianti a fonti rinnovabili. Ma in futuro, quando saranno completate le "valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete", ai sistemi di accumulo verrà riservato un iter di connessione alla rete analogo a quello previsto per impianti a fonti non rinnovabili e cogenerativi non ad alto rendimento.