Carrello
Seleziona il distributore
Seleziona il distributore che desideri utilizzare per il tuo carrello.
Distributore
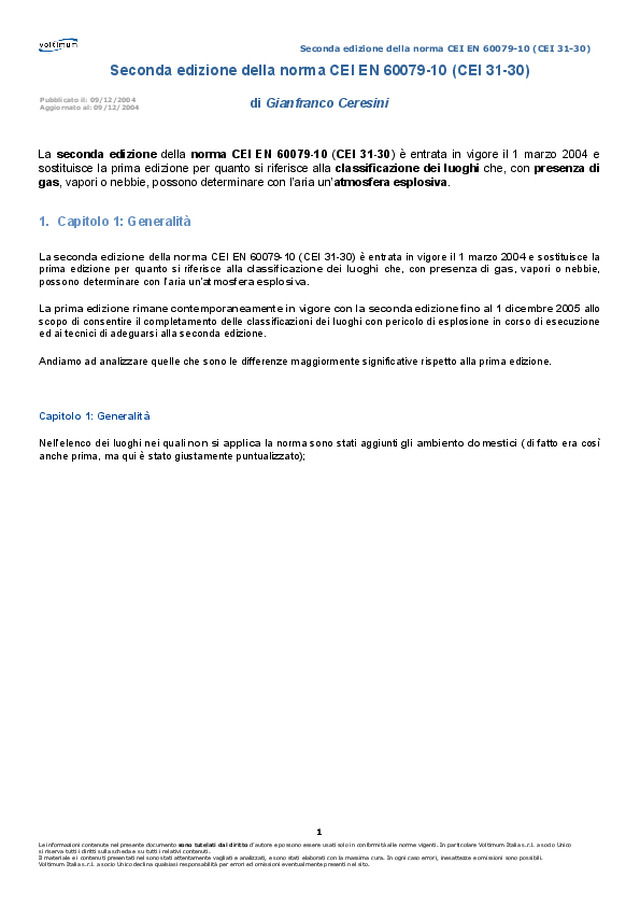
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 2 2. Capitolo 2: Definizioni 1. É stata aggiunta la definizione di Atmosfera esplosiva, recentemente introdotta dalla direttiva Atex 99/92/CE (Dlgs 233/03): “Miscela con aria, di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore, nebbia o polvere, in condizioni atmosferiche, in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga a tutta la miscela incombusta”; 2. Sono state aggiornate anche le definizioni di Zona 0, Zona 1 e Zona 2, ovviamente non stravolgendone il significato: o Zona 0: Luogo in cui un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili, sotto forma di gas, vapore o nebbia, è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente; o Zona 1: Luogo in cui, occasionalmente, è probabile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili, sotto forma di gas, vapore o nebbia; o Zona 2: Luogo in cui non è probabile che sia presente un’atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia durante il funzionamento normale,e/ o se ciò avviene, è possibile persista solo per brevi periodi; 3. É stata leggermente modificata la definizione di funzionamento normale di un impianto, laddove si aggiunge che “Guasti quali rottura di tenute di pompe, di guarnizioni, di flange, o spandimenti accidentali che richiedono riparazioni urgenti o fermate, non sono considerate far parte del funzionamento normale e neppure sono considerati alla stregua di guasti catastrofici. Il funzionamento normale comprende le condizioni di avvio e di fermata”; 4. Sono state aggiunte le seguenti due definizioni: o Estensione della zona “Distanza, in qualsiasi direzione, dalla sorgente di emissione verso il punto in cui la miscela di gas/aria è stata diluita dall’aria sino ad un valore al di sotto del limite inferiore di esplodibilità”; o Gas liquefatto infiammabile “Sostanza infiammabile depositata o manipolata sotto forma liquida e che, a temperatura ambiente e pressione atmosferica, diviene un gas infiammabile”;
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 3 3. Capitolo 3: Sicurezza e classificazione dei luoghi 1. È stato aggiunta la seguente frase: “È importante esaminare le parti delle apparecchiature di processo e dei sistemi dalle quali può esservi un’emissione di sostanze infiammabili e prendere in considerazione l’ipotesi di modificare il progetto per minimizzare la probabilità e la frequenza di tali emissioni e la quantità e la portata delle emissioni di sostanze. Queste considerazioni fondamentali dovrebbero essere valutate nella fase preliminare dello sviluppo del progetto di ogni impianto e dovrebbero riceve un’attenzione prioritaria nello studio della classificazione dei luoghi”; 2. Mentre è stata cancellata la seguente frase: “In situazioni di emergenza deve essere prevista la possibilità di interrompere l’alimentazione dell’impianto elettrico non idoneo, arrestare l’impianto di processo, intercettare le apparecchiature di processo, contenere le fuoriuscite e, se possibile, azionare un sistema di ventilazione addizionale di emergenza”;
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 4 4. Capitolo 4: Procedimento di classificazione dei luoghi 1. É stata aggiunta questa fondamentale frase: “La classificazione dei luoghi dovrebbe essere effettuata quando siano disponibili gli schemi e le planimetrie iniziali delle linee di produzione e della strumentazione e dei piani iniziali dell’impianto i quali siano poi confermati prima dell’avvio dell’opera. Durante la vita dell’impianto dovrebbero essere effettuate revisioni”; 2. Per quanto riguarda la determinazione delle sorgenti di emissione, troviamo questa aggiunta, che tende ad escludere l’utilizzo di questa classificazione ai laboratori: “Se la quantità totale di sostanza infiammabile disponibile per l’emissione è “piccola”, per esempio per l’uso in laboratorio, sebbene possa sussistere un pericolo potenziale, questa procedura di classificazione dei luoghi potrebbe non essere appropriata. In tali casi, si deve tenere conto dei particolari rischi che possono insorgere. Nella classificazione dei luoghi in cui è posta l’apparecchiatura di processo, nella quale la sostanza infiammabile viene bruciata, per esempio, bruciatori, forni, caldaie, turbine a gas, ecc., dovrebbero essere tenuti in considerazione il ciclo di lavaggio, le condizioni di avviamento o di fermata”; 3. Per quanto riguarda il tipo di zona è stata annessa la seguente lunga nota: “Quando le zone formate da sorgenti adiacenti di emissioni si sovrappongono e sono di differente classificazione, all’area di sovrapposizione verrà applicata la classificazione di rischio più elevata. Se le zone di sovrapposizione hanno la stessa classificazione, si applicherà questa classificazione comune. Tuttavia, bisogna prestare attenzione quando le zone di sovrapposizione si riferiscono a sostanze infiammabili che appartengano a classi di temperatura e/o apparecchiature diverse. Così, per esempio, se la zona 1 IIA T3 si sovrappone alla zona 2 IIC T1, la classificazione della sovrapposizione come zona 1 IIC T3 può risultare troppo restrittiva, ma la classificazione come zona 1 IIA T3, oppure con zona 1 IIC T1 potrebbe non essere accettabile. In questo caso, la classificazione dell’area sarà zona 1 IIA T3 e zona 2 IIC T1”; 4. Nella parte dedicata all’estensione della zona troviamo una significativa aggiunta, che recita in questo modo: “L’estensione della zona dipende dalla distanza stimata o calcolata in cui è presente un’atmosfera esplosiva prima di disperdersi ad un livello di concentrazione in aria al di sotto del limite inferiore di esplodibilità. Per valutare l’estensione della zona pericolosa, si dovrebbe consultare un esperto. Si dovrebbe sempre prestare attenzione alla possibilità che un gas più pesante dell’aria possa fluire in punti al di sotto del livello del suolo (per esempio le fosse o le depressioni) e che un gas più leggero dell’aria possa stagnare nei livelli più alti (per esempio sotto il soffitto). Quando una sorgente di emissione è posta all’esterno di un’area, o in un’area contigua, la penetrazione di una quantità significativa di gas o di vapori infiammabili in tale area può essere impedita utilizzando mezzi atti allo scopo, quali: o barriere fisiche; o mantenendo una sovrapressione sufficiente rispetto alle aree pericolose adiacenti, in modo da impedire l’ingresso dell’atmosfera esplosiva per la presenza di gas; o lavando l’area con un flusso adeguato di aria fresca, in modo da assicurare che l’aria fuoriesca dalle aperture in cui possa penetrare il gas o vapore infiammabile; 5. Successivamente, quando si parla del limite inferiore di esplodibilità (LEL), è stato aggiunto che “L’esperienza ha dimostrato che un’emissione di ammoniaca, avendo un LEL del 15% in volume, si dissiperà rapidamente all’aria aperta, in tal modo l’atmosfera esplosiva sarà di estensione trascurabile”. Una considerazione del genere era scritta come nota nella prima edizione della norma; 6. Sulla ventilazione è stato aggiunta una considerazione sull’involucro di un compressore: “L’involucro (cabinato) di un compressore con un grande ventilatore a soffitto e con aperture laterali sufficienti per permettere la libera circolazione dell’aria attraverso tutte le sue parti è considerato come ben ventilato e dovrebbe essere assimilato ad un luogo aperto (cioè di “grado” medio e “buona” disponibilità); 7. Aggiunta di tre note in calce all’articolo che tratta della densità relativa del gas o vapore al momento del rilascio: o Con gas o vapori più leggeri dell’aria, una fuoriuscita a bassa velocità si disperderà abbastanza rapidamente verso l'alto; la presenza di un tetto, comunque aumenta inevitabilmente l'area di espansione al di sotto. Se la fuoriuscita avviene ad alta velocità sotto forma di getto libero, l’azione
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 5 del getto, benché l’aria in ingresso diluisca il gas o il vapore, può aumentare la distanza nella quale permane la miscela gas/aria al di sopra del suo limite inferiore di infiammabilità; o Con gas o vapori più pesanti dell'aria, una fuoriuscita a bassa velocità tenderà a fluire verso il basso e può percorrere lunghe distanze sul terreno prima che si disperda in sicurezza per la diffusione atmosferica. Si deve, quindi, prestare particolare attenzione alla topografia di qualsiasi sistema considerato e anche l’area circostante per determinare dove i gas o i vapori possano raccogliersi in cavità, o scivolare verso livelli inferiori. Se la fuoriuscita avviene ad alta velocità sotto forma di getto libero, l’azione del getto dovuta alla penetrazione nell’aria può ridurre la miscela di gas/aria al di sotto del limite inferiore di infiammabilità ad una distanza inferiore a quella del caso di fuoriuscita a bassa velocità; o Bisogna prestare attenzione nella classificazione che contiene gas criogeni infiammabili, come il gas naturale liquido. I vapori emessi possono essere più pesanti dell'aria a temperature basse e diventano più leggeri dell’aria quando la loro temperatura si avvicina a quella dell’ambiente; 8. Per quanto riguarda altre grandezze da considerare nella valutazione dell’estensione della zona pericolosa, la vecchia norma indica solo citandole, le condizioni climatiche e la topografia, mentre nella nuova edizione, vengono effettuate analisi più dettagliate su queste due grandezze: o Condizioni climatiche: La velocità di dispersione del gas o vapore nell’atmosfera aumenta con la velocità del vento, ma vi è un minimo di velocità di 2m/s – 3m/ s richiesto per iniziare la diffusione per turbolenza; al di sotto di questa velocità, la formazione di strati di gas o di vapore e la distanza per una dispersione in sicurezza aumentano considerevolmente. Nelle aree dell’impianto schermate da grandi serbatoi e strutture, la velocità di movimento dell’aria può essere sostanzialmente inferiore a quella del vento, tuttavia, gli ostacoli al movimento dell’aria dovuti ad elementi dell’apparecchiatura tendono a mantenere la turbolenza anche a basse velocità del vento. a. Nota 1: Nell’Allegato B (art. B.4), una velocità del vento di 0,5 m/s è considerata appropriata per determinare le portate a cui la ventilazione in un ambiente esterno diluisce una fuoriuscita di sostanze infiammabili. Questo valore inferiore alla velocità del vento è appropriato a questo scopo, di mantenere un approccio prudente, anche se è noto che la tendenza a depositarsi in strati può compromettere il calcolo; b. Nota 2: Nella pratica normale la tendenza a disporsi su strati non viene tenuta in considerazione nella classificazione del luogo, in quanto le condizioni che danno origine a questa tendenza sono rare e si presentano solo per brevi periodi. Tuttavia, in caso vengano previsti periodi prolungati di vento debole, in certe circostanze, l’estensione della zona dovrebbe tenere in considerazione la distanza supplementare richiesta per poter ottenere la dispersione;
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 6 5. Allegato B: Ventilazione 1. L’introduzione viene cambiata in questo modo, nella sua parte centrale: “I metodi sviluppati consentono di determinare il tipo della zona attraverso: o la stima della portata di ventilazione minima richiesta per prevenire la formazione di un’atmosfera esplosiva significativa; o il calcolo un volume ipotetico Vz che permette di determinare il grado di ventilazione; o la valutazione del tempo di persistenza dell’emissione; o la determinazione del tipo di zona e del grado e la disponibilità della ventilazione, nonché il grado dell’emissione facendo uso della Tabella B.1 della norma (che non è mutata); o la verifica che il luogo e i tempi di persistenza siano compatibili. Non è previsto che questi calcoli vengano impiegati nella determinazione diretta dell’estensione dei luoghi pericolosi; 2. La nota relativa alla ventilazione naturale è uguale a quella della prima edizione della norma, se non per la parte finale; infatti si chiude con la seguente frase “La velocità del vento spesso può essere superiore a 2 m/s, tuttavia, in particolari casi, può essere inferiore a 0,5 m/s (per esempio sulla superficie vicino al suolo); 3. Per quanto riguarda invece la ventilazione artificiale, cambiano due requisiti di progettazione del sistema, e precisamente il secondo e il terzo, che diventano i seguenti (sono sottolineate le parti aggiunte): o dovrebbe essere presa in considerazione la classificazione all’interno e immediatamente al di fuori del punto di scarico del sistema di estrazione e delle aperture del sistema di estrazione; o per la ventilazione di un luogo pericoloso, l’aria dovrebbe essere normalmente aspirata da un luogo non pericoloso, tenendo in considerazione gli effetti di aspirazione sull’area circostante; 4. Quando parla del grado alto di efficacia della ventilazione, la seconda edizione della norma prende in considerazione l’ipotesi che oltre la zona di estensione trascurabile, ci possa essere un altro tipo di zona. Infatti si afferma che “Quando la ventilazione è in grado di ridurre la concentrazione in prossimità della sorgente di emissione in modo praticamente istantaneo, limitando la concentrazione al di sotto del LEL. Ne risulta una zona di piccola estensione. Tuttavia, quando la disponibilità della ventilazione non è buona, un’altro tipo di zona può circondare la zona di estensione trascurabile (vedere sempre la Tabella B.1); 5. Sono state poi inserite delle utili, anche se non si possono definire rivoluzionarie considerazioni, che non ci sono nella vecchia edizione, sulla valutazione del volume ipotetico Vz e sulla relazione tra il volume ipotetico di Vz e le dimensioni dell’area pericolosa: “Il volume ipotetico Vz rappresenta il volume nel quale la concentrazione media del gas o vapore infiammabili è di 0,25 o 0,5 volte il LEL, in funzione del valore del fattore di sicurezza k. Ciò significa che, ai limiti dell’ipotetico volume stimato, la concentrazione di gas o vapore è significativamente inferiore al LEL, vale a dire che il volume nel quale la concentrazione è superiore al valore di LEL sarà più piccolo di Vz. Il volume ipotetico Vz fornisce un’indicazione per il volume infiammabile originato da una sorgente di emissione, tale volume non sarà normalmente uguale al volume del luogo pericoloso. Innanzitutto, la forma del volume ipotetico Vz non è definita e risentirà delle condizioni di ventilazione; il grado e la disponibilità della ventilazione e le possibili variazioni di questi parametri influenzeranno la forma del volume ipotetico Vz. Successivamente si dovrà definire la posizione di tale ipotetico volume rispetto alla sorgente di emissione. Questa dipenderà principalmente dalla direzione di ventilazione con l’ipotetico volume posto sottovento. In terzo luogo, in molte situazioni (per esempio le condizioni all’aperto) si deve prestare attenzione alla possibilità del cambiamento di direzione della ventilazione. Così il volume del luogo pericoloso a causa di una data sorgente di emissione, generalmente, non corrisponderà al volume ipotetico Vz ma potrebbe essere molte volte più grande di questo. Per calcolare il volume ipotetico è necessario per prima cosa stabilire la portata minima teorica di aria di ventilazione (dV/dt) min , necessaria a diluire una data emissione di sostanze infiammabili sino alla concentrazione richiesta più bassa del limite inferiore di esplosione”. La formula per calcolare questa portata minima teorica di aria di ventilazione è la stessa della vecchia edizione della norma (formula B.1); 6. Mentre la formula B.2 della vecchia norma indica il volume ipotetico Vz di atmosfera esplosiva attorno alla sorgente di emissione, la formula B.2 della seconda edizione (identica come espressione) indica un volume Vk come relazione tra il valore calcolato (dV/dt)min e la portata effettiva di ventilazione nel
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 7 volume considerato (Vo) in prossimità della sorgente di emissione. In una nota viene precisato che “quando all’interno del volume di ventilazione considerato (Vo), sono presenti sorgenti multiple di emissione, è necessario determinare il valore di (dV/dt) min per ciascuna sorgente di emissione e loro grado. Le portate così determinate dovrebbero essere sommate come indicato in una tabella B.2” (che non è presente nella prima edizione). Viene inoltre detto, in un’altra nota, che “per le situazioni al chiuso, Vo generalmente rappresenterà il volume del locale o dell’edificio considerato, a meno che vi sia una ventilazione e un locale specifici da prendere in considerazione”. Il volume Vz viene indicato nella nuova CEI 31-30, solo alla formula B.4, dove viene introdotto il fattore f di efficacia della ventilazione, il quale moltiplicato per il volume precedente Vk fa ottenere Vz (la formula B.4 è uguale alla formula B.3 della vecchia edizione); 7. La norma passa poi ad analizzare la situazione dei luoghi all’aperto, fornendo un esempio più circostanziato rispetto alla precedente edizione: “In un luogo all’aperto, velocità del vento anche molto basse determinano un numero elevato di ricambi d’aria. Si consideri, per esempio, un ipotetico cubo all’aperto avente dimensioni di 15 m. In questo caso, una velocità del vento di 0,5 m/s garantisce una portata d’aria di ricambio maggiore di100/h (0,03/s), con un volume Vo di 3400 m 3 ”. La formula che viene fornita qui, per la valutazione di Vz in un luogo aperto, è differente rispetto a quella della prima edizione della norma: la diversità sta nell’aver inserito il coefficiente moltiplicativo f (fattore di efficacia della ventilazione), con la seguente avvertenza testuale “a causa del diverso meccanismo di dispersione, normalmente più rapida in situazioni all’aperto, questa equazione generalmente fornirà un volume sovrastimato. Per evitare il presentarsi di una tale situazione, si dovrebbe prestare attenzione nella scelta di un valore di f realistico”; 8. É stata aggiunta anche una valutazione sulle situazioni all’aperto limitate: “Se il volume di ventilazione è piccolo (per esempio un separatore di acqua-olio) come 5 m × 3 m × 1 m (Vo = 15 m 3 ) e la velocità del vento è di 0,05 m/s allora il valore di C sarà 35/h (0,01/s)”; 9. Dove più avanti si parla del grado di ventilazione alto, la nuova edizione della norma fornisce una indicazione numerica su quello che può essere un volume Vz trascurabile: “Il grado della ventilazione può essere considerato alto (VH) solo quando una valutazione del rischio mostra che il livello dei danni potenziali, dovuti al rapido aumento della temperatura e/o della pressione, a seguito di un’accensione di un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas di volume Vz, è molto piccolo o trascurabile. La valutazione dei rischi dovrebbe prendere in considerazione anche gli effetti secondari (per esempio, ulteriori emissioni di sostanze infiammabili). Le condizioni sopra indicate si applicheranno normalmente quando il valore di Vz è inferiore a 0,1 m 3 . In questa situazione il volume del luogo pericoloso può essere considerato come uguale a Vz. In una nota successiva è aggiunto “Quando i calcoli per definire Vz si basano sulla ventilazione artificiale, bisogna fare alcune considerazioni sul modo in cui questa ventilazione sia attuata; così spesso il flusso principale di aria di ventilazione deve essere prelevato dalla sorgente di emissione, e la diluizione avvenga in una direzione che si allontani dalla sorgente potenziale d’innesco, per esempio nel caso di sistemi di aspirazione locali, o quando la ventilazione di diluizione venga fornita in un involucro relativamente piccolo, come un laboratorio o nell’involucro di un impianto pilota”; 10. Il grado di ventilazione basso viene così definito “Il grado di ventilazione deve essere considerato basso (VL) se il volume Vz è superiore a Vo. Il grado basso (VL) non dovrebbe generalmente riscontrarsi in situazioni all’aperto, eccetto dove ci siano restrizioni al flusso dell’aria, ad esempio nelle fosse o pozzetti”; 11. Poi è la volta del grado di ventilazione medio “Se il grado di ventilazione non è ne alto (VH) né basso (VL) lo si deve considerare come medio (VM). Normalmente il volume Vz risulta spesso più piccolo o uguale a Vo. La ventilazione considerata media dovrebbe controllare la dispersione dell’emissione del gas o del vapore infiammabili. Il tempo impiegato per disperdere un’atmosfera esplosiva dopo l’arresto dell’emissione dovrebbe essere tale da rispettare le condizioni sia della zona 1 sia della zona 2, a seconda che l’emissione sia di primo o secondo grado. Il tempo di dispersione accettabile dipende dalla frequenza e dalla durata previste per ogni emissione. Quando il volume Vz è significativamente più piccolo del volume del luogo al chiuso, può essere ammesso classificare come pericolosa solamente una parte di detto luogo. In alcuni casi, in funzione delle dimensioni del luogo chiuso, il volume Vz può risultare simile al volume del luogo chiuso. In tal caso, tutto detto luogo dovrebbe essere classificato come pericoloso. All’aperto, tranne nei casi in cui Vz sia molto piccolo, o quando non vi siano significative limitazioni al flusso dell’aria, la ventilazione dovrebbe essere considerata come media (VM)”; 12. Sono state aggiunte le due tabelle B.2 e B.3 che qui riportiamo, ricordando che le equazioni da B.2 a B.6 citate, si riferiscono al volume Vk (B.2), al numero di ricambi d’aria C (B.3), al volume Vz nei luoghi al chiuso (B.4), al volume Vz nei luoghi all’aperto (B.5) e al tempo di persistenza t (B.6). Il riferimento per le formazione delle tabelle viene dall’Istituto di Ingegneria dei Gas del Regno Unito.
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 8 Grado di emissione Azione da intraprendere (dV/dt) min Continuo Sommare tutti i valori per (dV/dt) min e applicare il totale alle equazioni da B.2 a B.6 Primo Conformemente alla Tab. B.3, sommare i valori maggiori di (dV/dt) min richiesti e applicare il totale alle equazioni da B.2 a B.6 Secondo Utilizzare solo il valore maggiore di (dV/dt) min e applicarlo alle equazioni da B.2 a B.6 Nota: Il valore risultante di (dV/dt) min per ciascuna riga della tabella dovrebbe essere applicato alla Tab. B.1. Non è necessario sommare i differenti gradi di emissione. Tabella B.2 - Procedura per il calcolo delle emissioni multiple in un volume Vo Numero di emissioni di primo grado Numero di emissioni di primo grado che devono essere utilizzate in accordo con la Tabella B.2 1 1 2 2 3-5 3 6-9 4 10-13 5 14-18 6 19-23 7 24-27 8 28-33 9 34-39 10 40-45 11 46-51 12 Tabella B.3 - Procedura per il calcolo di emissioni multiple di primo grado 13. Nei successivi esempi di calcoli per la determinazione del grado di ventilazione, sono cambiate, nella nuova edizione della norma, tutte le conclusioni.
Seconda edizione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito. 9 6. Allegato C: Esempi di classificazione dei luoghi pericolosi Non ci sono differenze negli esempi proposti.